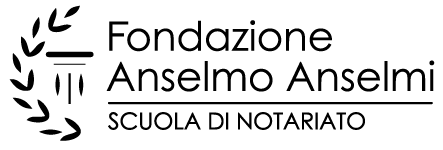SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA. COSTITUZIONE CON SOCIO PERSONA GIURIDICA (ART. 2463 BIS C.C.).
Commissione Massime di Diritto Societario – Consiglio Notarile di Roma
(approvata il 25 settembre 2024)
Società a responsabilità limitata semplificata. Costituzione con socio persona giuridica (art. 2463 bis c.c.).
MASSIMA
Ferma la validità dell’atto costitutivo e ferma la perdita dei benefici fiscali, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese di una società a responsabilità limitata semplificata con socio diverso da persona fisica, è necessario che i soci procedano all’integrazione dello statuto recependo le regole di funzionamento della s.r.l. “ordinaria” in conseguenza della automatica “riqualificazione” dell’ente in società a responsabilità limitata, a capitale esiguo o non, a seconda dell’importo del capitale sociale destinato.
MOTIVAZIONE
La molteplicità degli interventi legislativi che hanno interessato la società a responsabilità limitata negli ultimi anni è un dato incontestabile come lo è la nuova “conformazione” del “tipo S.R.L.” per come ridisegnato dalle incisive innovazioni in materia, tutte connotate da specifiche finalità di incentivo all’esercizio dell’attività di impresa in forma collettiva e tutte caratterizzate dal comune denominatore del riconoscimento di benefici fiscali e talora anche concorsuale. Il percorso riformatore ha trovato le prime sue espressioni nella previsione della possibilità di costituire s.r.l. a capitale “ridotto” o esiguo, di costituire s.r.l. semplificate con adozione di statuto standard con esenzione da onorari notarili, diritti di segreteria e di bollo, ed è poi proseguito con il riconoscimento della costituzione di S.R.L. che costituiscano involucro di start up o incubatori e PMI (con riconoscimento di benefici fiscali ed esenzione dalle procedure concorsuali)[1], fino ad approdare alle recenti innovazioni riguardanti aspetti della circolazione delle partecipazioni sociali e della sollecitazione all’investimento. Allo stesso tempo, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, recependo peraltro autorevoli opinioni dottrinali, ha in più occasioni ribadito la natura speciale della disciplina dettata in tema di start up e PMI innovative non in funzione della caratterizzazione di un tipo di società a responsabilità limitata a se stante e giammai in funzione della declaratoria di nullità dell’atto costitutivo, ma in funzione della sola permanenza dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese in presenza dei presupposti di legge per il godimento dei benefici fiscali e della esenzione dalle procedure concorsuali, fermo il potere “riqualificatorio” del Giudice, ossia di applicazione della disciplina “ordinaria” ove in concreto gli elementi previsti dalla legislazione speciale non sussistano. E ciò, ora anche secondo la Suprema Corte, in considerazione del “doppio binario” della pubblicità nel registro imprese per le start up e PMI innovative[2]: pubblicità costitutiva per la S.R.L. “involucro”, e pubblicità dichiarativa per tutti gli elementi riconducibili alle dichiarazioni rese dall’organo amministrativo ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale. Queste ultime, ricondotte nell’alveo delle dichiarazioni amministrative, potrebbero essere oggetto di verifica formale in sede di iscrizione e successivamente del potere “riqualificatorio” da parte del Tribunale, riqualificazione che, tuttavia, determina, nella fase patologica del rapporto, solo la perdita dei benefici fiscali e la sottoposizione a procedura concorsuale della società, che rimane iscritta nella sezione ordinaria e che continua a funzionare sulla base delle regole già contenute nello statuto originario e (qui) eventualmente integrate dai soci con un atto di “adeguamento” in funzione dell’avvenuta “riqualificazione” (atto non sempre necessario poiché in concreto lo statuto potrebbe già consentire il regolare funzionamento dell’ente come società non PMI e/o non start up).
E’ evidente che la chiave esegetica fornita dalla Suprema Corte[3] debba essere utilizzata per la soluzione di tutte le questioni dubbie, prime fra tutte quelle relative alla costituzione di società a responsabilità limitata semplificata ove, in generale, le prescrizioni testuali dello statuto standard non siano pedissequamente rispettate (si pensi alla previsione della durata o alla nomina di più amministratori in regime di amministrazione plurima disgiuntiva) o, come nella fattispecie al vaglio, partecipino alla costituzione della società enti e/o persone giuridiche.
Evidentemente, il percorso riformatore era, all’epoca dell’introduzione della s.r.l.s., ancora agli inizi e non fu previsto un sistema di doppio binario pubblicitario, ma le esigenze perseguite e preservate anche dai successivi interventi legislativi, sono analoghe a quelle perseguite con la legislazione speciale in tema di start up e PMI innovative: il risparmio fiscale e l’incentivo all’esercizio di attività di impresa in forma collettiva. In questa prospettiva, la scelta dei soci di costituire una s.r.l. adottando lo statuto ministeriale secondo quanto previsto dall’art. 2463bis c.c. trova la sua giustificazione causale non nella scelta di un tipo a se stante, ma nel risparmio fiscale e degli onorari notarili collegato all’adozione dello statuto standard.
Alla luce di questo nuovo e complesso quadro normativo, emerge che questo unitario tipo sociale è divenuto un modello astrattamente utilizzabile, in virtù di specifica previsione normativa, per il perseguimento di specifici interessi meritevoli di tutela e che il legislatore incentiva mediante la previsione di benefici di carattere fiscale e di esenzioni dalla disciplina del fallimento (ora codice della crisi di impresa). Così come per la s.r.l. start up o alla s.r.l. PMI innovativa è acclarata l’esistenza di una s.r.l. ordinaria che costituisce “involucro” della “disciplina speciale” della start up o della PMI[4] (che ne consente l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e le conseguenti agevolazioni fiscali ma non snatura le caratteristiche del tipo che “riemergono” automaticamente in caso di mancanza o al momento del venir meno dei requisiti previsti dalla legislazione speciale[5]), anche nell’atto costitutivo di s.r.l.s. deve ritenersi presente la matrice essenziale della s.r.l. ordinaria (o a capitale esiguo a seconda dell’importo destinato), come altresì dimostrato dalla possibilità che le regole di funzionamento della s.r.l.s. ordinaria siano introdotte manente societate senza che ciò comporti trasformazione in senso tecnico ma mera modifica statutaria, stante l’identità del tipo.
In particolare, si può ritenere che analogo meccanismo a quello declinato per le s.r.l. start up e PMI operi per la s.r.l.s. ove costituita da socio persona giuridica e più in generale ove non vi sia in concreto conformità allo statuto ministeriale. Da ciò discende che l’atto costitutivo non è nullo, stante la tassatività delle cause di nullità e la mancanza di una norma imperativa che espressamente la preveda per il caso di specie, ferma la perdita dei benefici fiscali riconosciuti per la s.r.l.s., con conseguente inevitabile recupero da parte dello Stato delle agevolazioni previste dalla legge per detta variante.
L’atto sarà altresì iscrivibile ove sia adottata dai soci la modifica/integrazione dello statuto in funzione dell’adeguamento (ex lege) alle norme della s.r.l. ordinaria. Nel caso di specie, la decisione dei soci avrebbe la funzione di “recepire” nello statuto sociale le regole di funzionamento della s.r.l. ordinaria (a capitale esiguo o non a seconda dell’importo del capitale sociale)[6].
In conclusione, alla luce di quanto esposto in considerazione del nuovo sistema della S.R.L., nella fattispecie in esame la mancanza della previsione di una causa di nullità determina l’inapplicabilità del regime di cui agli artt. 28 e 138 l. n.[7].
[1] Cfr. l’originaria formulazione del d.l. 179/2012, nonché la disciplina della s.r.l. «PMI innovativa» per come regolata dall’art. 4 del d.l. 3/2015 e nell’accezione attuale di «s.r.l. PMI» derivante dalle modifiche introdotte dal d.l. 50/2017 e successive modifiche.
[2] Sul tema, cfr. Miceli, Note in tema di pubblicità delle s.r.l. PMI, in Irrera (a cura di), La società a responsabilità limitata: un modello transtipico, Studi in onore di Oreste Cagnasso; Giappichelli, 2020, 218 ss.; Miceli, La pubblicità delle s.r.l. PMI, Cagnasso e Mambriani (diretto da), Start up e PMI innovative, Zanichelli – Torino, 2020, 765-769.
[3] Si vedano Cass., 4 luglio 2022, n. 21152 e Cass., 2 agosto 2022, n. 23980, in corso di pubblicazione in Nuovo dir. soc. In considerazione della rilevanza ai fini del presente lavoro dei due principi di diritto enunciati dalla Corte, sembra opportuno evidenziare quanto segue. 1) Con l’ordinanza del 4 luglio 2022, n. 21152 la Cassazione accoglie il ricorso proposto dal Fallimento contro la revoca della dichiarazione di fallimento di una start up innovativa decisa dalla Corte di Appello di Trieste cassando con rinvio ad altra sezione in diversa composizione, ritenendo infondate le ragioni della revoca, che per la Corte territoriale risiederebbero nell’indebita estensione da parte del Tribunale della «propria cognizione alla verifica in concreto dei requisiti» per la qualifica della società come start up poiché spetterebbe solo all’Ufficio del Registro delle imprese intervenire a posteriori per verificare la sussistenza ab origine dei requisiti autocertificati dal legale rappresentante e procedere, in caso di mendacio, alla cancellazione dalla sezione speciale, ferma l’iscrizione nella sezione ordinaria. La Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, argomenta sul duplice piano della natura dell’autocertificazione del legale rappresentante della start up di cui all’art. 25 del d.l. n. 179/2012, convertito nella l. n. 221/2012 e della natura dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, e precisamente: – esclude a monte l’esistenza di «presunzione di veridicità» per l’autocertificazione resa dal legale rappresentante della start up innovativa ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e dell’aggiornamento periodico circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dell’art. 25, e riconduce l’effetto di detta dichiarazione a quello delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 2000, evidenziandone la natura «amministrativa» e negando di conseguenza che possa costituire prova ex se in sede giudiziale, dovendo essere invece adeguatamente valutata dal giudice la veridicità del suo contenuto, e ciò a prescindere dalla responsabilità penale del dichiarante; – riconosce l’esistenza del sindacato giudiziale dell’effettivo e concreto possesso da parte della start up dei requisiti di legge, negando, in generale, l’effetto costitutivo/sanante della iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese; effetto che viene dalla Corte ricondotto nell’alveo della pubblicità notizia quale «regola» delle iscrizioni nelle sezioni speciali del predetto registro, salvo diversa previsione normativa, manchevole nella fattispecie al vaglio.2) Con l’ordinanza del 2 agosto 2022, n. 23980 la Cassazione rigetta il ricorso presentato contro la sentenza della Corte di Appello di Venezia depositata il 2 dicembre 2019, che aveva a sua volta rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. contro la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Padova il 17 luglio 2019 nei confronti di una start up innovativa costituita in data 6 novembre 2013, ma iscritta nella sezione speciale delle start up innovative solo in data 27 giugno 2016. Nel chiarire le ragioni del rigetto, la Suprema Corte afferma che il termine quinquennale (o il minor termine di legge) per l’esclusione dell’assoggettamento a procedure concorsuali, decorre dalla data della costituzione della società e non dalla data del deposito presso il registro delle imprese della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali per conseguire l’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative. E ciò, pur nella consapevolezza del dibattito dottrinale sul tema, si afferma in base a quanto si desume dalla formulazione dell’art. 25 del d.l. 179/2012, che al 2° co. lett. b, esclude in radice che possa qualificarsi «start up innovativa» una società costituita da più di cinque anni e dall’art. 31, comma 4 del predetto decreto che prevede la cessazione della disciplina di favore per le start up innovative «in ogni caso» alla «scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione» della società, nonché dalla relazione illustrativa al decreto legge, ove si evidenzia che l’esenzione dalle procedure concorsuali «opera naturalmente in presenza della qualifica di start up innovativa e in particolare soltanto nel corso dei primi quattro [ora cinque] anni dalla costituzione della società». Inoltre, la Corte evidenzia che per «costituzione», ai sensi dell’art. 25 d.l. 179/2012, deve intendersi «nascita» della società e, considerato che possono rivestire la qualifica di start up solo le società di capitali e cooperative, questo momento coincide non con la stipula dell’atto costitutivo, ma con l’iscrizione nel registro delle imprese, che per questi tipi sociali ha natura costitutiva ex art. 2331, comma 1, c.c. I due provvedimenti costituiscono un importante momento chiarificatore nel complesso panorama normativo ed interpretativo relativo alla disciplina della pubblicità delle start up e PMI innovative. La Suprema Corte, partendo dall’analisi del testo normativo, pone a base delle due decisioni la constatazione degli elementi di «specialità» della disciplina sia rispetto al procedimento per l’attuazione della pubblicità nel Registro delle imprese, sia rispetto agli effetti che derivano dalla pubblicità, e da queste premesse afferma la piena compatibilità tra il potere di controllo formale del registro delle imprese sugli atti presentati per l’iscrizione nella sezione speciale e «[…] il più ampio sindacato di merito su quegli stessi atti che spetta all’autorità giudiziaria competente ad esaminare la domanda di fallimento della start up medesima», nonché il momento della decorrenza del termine di non assoggettabilità a procedure concorsuali.
Sul tema, si veda pure Trib. Roma (sent.), 5 aprile 2019, in Giur. it., 2020, 126 ss.
[4] Per una approfondita disamina delle caratteristiche della s.r.l. PMI, cfr., di recente, Cagnasso, La s.r.l. «aperta», in Cagnasso e Mambriani (diretto da), Start up e PMI innovative, Bologna, 2020, 227 ss.; Cagnasso, sub art. 2462, 1° co., in Cagnasso e Mambriani, Codice della società a responsabilità limitata, Roma, 2015, 4 ss.; Montalenti, Start up, PMI innovative: tipi, modelli e mercati finanziari, in Cagnasso e Mambriani (diretto da), Start up e PMI innovative, cit., 39 ss.; e per la distinzione tra start up e PMI innovative, si veda Garesio, Le fattispecie, in Cagnasso e Mambriani (diretto da), Start up e PMI innovative, cit., 51 ss.
[5] Si veda nota n. 3 con sintesi dei recenti principi giurisprudenziali sul tema.
[6] Peraltro, il meccanismo della riqualificazione è stato utilizzato dal legislatore anche con riferimento alle società a capitale ridotto: art. 9, comma 15, d.l. 76/13. Sul tema cfr. CIAN, Le società di capitali (a r.l.) “quasi a-capitalizzate”: spunti per una ricostruzione sistematica e della disciplina, in Nuove leggi civili commentate, 2014, p. 755 ss., il quale evidenzia la natura di “procedimento” dell’ art. 2463 bis c.c.
[7] Cfr. in senso sostanzialmente conforme, F. PERRECA, Efficacia performativa dei nomi, pubblicità e responsabilità professionale: il caso della costituzione di una s.r.l.s. con socio una persona giuridica, in Riv. not., 2022, p. 373 ss.; conclusione, che per le medesime ragioni sopra esposte, si ritiene di poter estendere anche alle ipotesi di previsione nell’atto costitutivo della s.r.l.s. della durata o del sistema di amministrazione plurima disgiuntiva o congiuntiva.