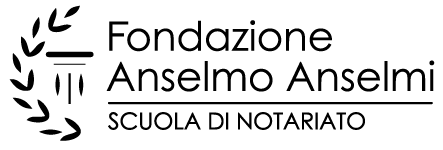TRASFORMAZIONE DA AZIENDA SPECIALE IN FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
Commissione Massime di Diritto Societario – Consiglio Notarile di Roma
(approvata il 18 luglio 2024)
Trasformazione da azienda speciale in fondazione di partecipazione.
E’ ammissibile la trasformazione da azienda speciale in fondazione di partecipazione. In tal caso, venendo in considerazione la disciplina della trasformazione eterogenea, l’operazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla pubblicità nel Registro delle Persone Giuridiche o nel Runts della decisione del Consiglio comunale o regionale o dell’assemblea consortile, con la possibilità per i creditori di proporre opposizione entro tale termine, salvo il loro consenso o il pagamento di quelli non consenzienti.
- Uno dei problemi centrali nella ricostruzione della disciplina codicistica relativa alla trasformazione è l’individuazione dell’ambito della sua ammissibilità.
Oggi il legislatore consente la trasformazione al di là dell’area societaria: in particolare prevede la trasformazione eterogenea da società di capitali in enti non societari e con scopo diverso da quello lucrativo e addirittura in comunioni di azienda, superando la barriera non solo sussistente tra società ed altri enti non societari, ma tra enti con scopi diversi e tra enti e una pluralità di soggetti. Ciò che sembra caratteristico dell’istituto della trasformazione è la continuità nell’esercizio dell’attività, in particolare di impresa o anche solo, nel caso del passaggio da società a comunione d’azienda, nei rapporti.
Il sistema delineato dal codice civile con l’espressa previsione e disciplina di varie ipotesi di trasformazione pone l’interrogativo in ordine all’ammissibilità di ulteriori ipotesi di trasformazione non previste. Secondo un orientamento minoritario in dottrina, si tratterebbe di un sistema chiuso, mentre l’orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza lo ricostruisce in senso aperto, al fine di favorire l’autonomia delle società e degli enti nella scelta del codice organizzativo più appropriato nei singoli casi o nei singoli momenti della loro vita. In tale prospettiva, sono ammissibili trasformazioni atipiche, differenti da quelle previste, in mancanza di limiti espressi o ricavabili dal sistema (Cfr., sul tema, CETRA, Le operazioni straordinarie negli enti del primo libro e negli enti del terzo settore, in Giur. comm., 2024, I, 532 ss. con un’ampia bibliografia a p. 533 ss.; CARRARO, in AA.VV., Trasformazioni a cura di A. Serra e I. Demuro, in Commentario del Codice Civile e dei codici collegati Scialoja – Branca – Galgano a cura di G. De Nova, Bologna, 2021, ove l’analisi dell’evoluzione storica dell’istituto della trasformazione, p. 236 ss.; CAPO, Le trasformazioni di società e in società, in Trattato delle società diretto da V. Donativi, I, Milano, 2022, 765 ss.).
Ad esempio, ci si è chiesti se l’espressa previsione della trasformazione delle società di capitali in altri enti possa essere di ostacolo all’ammissibilità della trasformazione di società di persone in altri enti. E’ così pure se sia ammissibile la trasformazione tra di loro degli enti previsti come punto di partenza o di arrivo della trasformazione eterogenea (oggi è prevista espressamente, all’art. 42 bis c.c., la trasformabilità delle associazioni in fondazioni e viceversa).
- Lo stesso legislatore delinea espressamente ulteriori ipotesi di trasformazioni, quali quella delle aziende speciali in società di capitali disciplinata dall’art. 115 T.u.e.l. (Cfr. QUARTA, La trasformazione eterogenea di una s.p.a. in azienda speciale, in Il nuovo diritto delle società, 2016, n. 17, 125 ss.; SANTUARI, Sulla trasformabilità dell’azienda speciale in società di captali alla luce del d. l. n. 95/2012 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, giustamm.it, settembre 2012; MALTONI – RUOTOLO, Il procedimento ex art. 115 T.U.E.L. di trasformazione e scissione di aziende speciali e consorzi di enti pubblici in società di capitali: l’adeguamento interpretativo alla disciplina vigente del codice civile. Studio di Imprese n. 120/2015 approvato dall’Area Scientifica – Studi di Impresa il 1° ottobre 2015.).
L’art. 114 offre la nozione e la disciplina dell’azienda speciale, intesa come ente strumentale, all’ente locale, soggetto al potere di indirizzo e di vigilanza di quest’ultimo, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, di statuto e obbligato all’iscrizione nel registro delle imprese ed al deposito del bilancio presso il medesimo.
La ricostruzione della fattispecie delineata dall’art. 115 veniva ricondotta, in una certa prospettiva, ad una particolare modalità di costituzione delle società di capitali, mentre, facendo leva soprattutto sul principio di continuità, veniva ricondotta ad un’ipotesi peculiare di trasformazione, con il dubbio se fosse da qualificare come omogenea o eterogenea.
In un ampio studio dedicato al tema, la risposta è stata nel primo senso o “meglio nell’escludere l’applicazione del diritto all’opposizione” (MALTONI – RUOTOLO, op. cit).
Il T.u.e.l., come è noto, è di data anteriore rispetto alla riforma delle società. Pertanto, si è posto il problema se le norme richiamate dovessero essere intese con il contenuto presente all’epoca oppure i richiami dovessero essere aggiornati ai nuovi dati normativi. Ed inoltre, come si è ricordato, l’introduzione della disciplina della trasformazione eterogenea ha posto il dubbio se e in che misura dovessero venire in considerazione tali regole e, in particolare, l’opposizione da parte dei creditori.
Con riferimento alla trasformazione di aziende speciali in società di capitali si è ritenuto che si trattasse di una trasformazione omogenea, anche alla luce della circostanza che tale operazione era prevista prima della riforma societaria e, se si ritenesse applicale la disciplina della trasformazione eterogenea, si sarebbero introdotte ulteriori strumenti di tutela prima non previsti.
Occorre sottolineare che l’operazione è posta in essere attraverso la deliberazione del consiglio comunale o regionale o dell’assemblea degli enti consorziati, che quindi deve avere contenuto, forma e pubblicità in conformità alle regole sulla trasformazione in società di capitali. Come nel caso delle c.d. privatizzazioni, si tratta di trasformazioni poste in essere da un soggetto differente dall’ente trasformando e non, come nei casi previsti dal codice civile, da deliberazioni interne allo stesso.
La seconda parte del primo comma dell’art. 115 T.u.e.l. disciplina le modalità di determinazione del capitale iniziale delle società di capitali derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali: quest’ultimo è fissato nella deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione dell’azienda speciale risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all’importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime; l’eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo dove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio dell’azienda.
La relazione prevista nel comma terzo dell’art. 115 è collegata a tale norma: infatti, ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, in un momento successivo rispetto alla trasformazione e precisamente entro tre mesi, gli amministratori devono richiede ad un esperto designato dal Presidente del Tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343, primo comma del codice civile (stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti). Entro sei mesi dal ricevimento gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione, e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. La norma aggiunge che fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva, le azioni delle società sono inalienabili.
Si tratta, a differenza della relazione nell’ambito della disciplina della trasformazione, di un documento posto in essere posteriormente all’operazione e non anteriormente. Il testo unico fa riferimento all’art. 2343 c.c. oggi, alla luce delle novità introdotte dalla riforma societaria successivamente, dovrebbero venire in considerazione per la s.r.l. le differenti regole previste nell’art. 2465 c.c. e per la s.p.a. i procedimenti alternativi descritti dall’art. 2343 bis.
- La fondazione di partecipazione, resa ammissibile in particolare per la previsione normativa di altre istituzioni di carattere privato, ulteriori rispetto alle associazioni e alle fondazioni, presente nell’art. 12 c.c. e ora nell’art. 1 D.P.R. 10 febbraio 2020, n. 361, costituisce una sorta di “ibrido” o, meglio, una variante della fondazione con caratteri propri dell’associazione. Infatti, ha in comune con la fondazione classica il vincolo di destinazione del patrimonio non modificabile; per contro, presenta una struttura partecipativa aperta con la possibilità di una pluralità di fondatori e di ulteriori aderenti; consente la partecipazione di fondatori o di ulteriori aderenti alla gestione; consente una formazione progressiva del patrimonio.
Ciò posto, è ammissibile la trasformazione di un’azienda speciale, ente pubblico, in una fondazione di partecipazione?
Accogliendo la tesi maggioritaria che ricostruisce il sistema in tema di trasformazione come aperto (un cenno sulla trasformazione come “mutamento formale nell’organizzazione societaria” in Cass., SS. UU., 30 luglio 2021, n. 21970, in Società, 2021, 1193) e tenendo conto che lo stesso legislatore prevede espressamente la trasformabilità delle aziende speciali in società di capitali all’art. 115 T.u.e.l., non pare sussistano ostacoli all’ammissibilità della trasformazione di aziende speciali in fondazioni di partecipazione (cfr., di recente, CAGNASSO, Trasformazione da azienda speciale in fondazione di partecipazione, Relazione tenuta in occasione del Convegno “Le fondazioni di partecipazione tra sistema e giurisprudenza” presso la Fondazione Anselmi, a Roma il 21 maggio 2024).
Si potrebbe anche estendere il ragionamento che è stato utilizzato per giustificare la trasformazione di società di persone negli enti punto di arrivo della trasformazione eterogenea. Si è osservato, con una sorta di ricorso alla proprietà transitiva, che, se una società di persone può trasformarsi in una società di capitali e quest’ultima in associazione, fondazione, consorzio, cooperativa, comunione di azienda, non si comprenda perché debba escludersi una trasformazione diretta (v. CAPO, op. cit., p. 820). Così l’azienda speciale può trasformarsi in una società di capitali per espressa previsione di legge e quest’ultima in una fondazione sempre per espressa previsione di legge: sembra quindi giustificabile, anche in questo caso, la trasformazione diretta.
- Quale disciplina della trasformazione viene in considerazione?
La disposizione inserita nelle norme dedicate alla trasformazione eterogenea regressiva da società di capitali in altri enti ed espressamente riferita alle fondazioni, contenuta nell’art. 2500 septies, quarto comma, c.c. stabilisce che la deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il codice civile ricollega all’atto di fondazione o alla volontà del fondatore.
Tale norma viene intesa, oltre che nell’ovvio significato del prodursi degli effetti dell’atto di fondazione, nella necessità che il procedimento si perfezioni attraverso il riconoscimento come persona giuridica e l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche o, se ente del terzo settore, l’iscrizione nel Runts.
Inoltre, come in tutte le ipotesi di trasformazione eterogenea, l’operazione ha effetto, ai sensi dell’art. 2500 novies c.c., dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti: salvo il consenso o il pagamento dei non consenzienti, i creditori possono, nel suddetto termine, fare opposizione.
La disciplina della trasformazione eterogenea di società di capitali prevede particolari maggioranze, il diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale a ciascun socio, il contenuto della responsabilità dei soci che rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali. Si tratta di norme, presenti nei commi primo, terzo e quarto dell’art. 2500 sexies c.c., che non vengono in considerazione nel nostro caso, ove si prevede la deliberazione degli enti locali e l’assenza di soggetti che diventeranno illimitatamente responsabili.
Per contro, assume rilievo il secondo comma dell’art. 2500 sexies. La norma prevede la predisposizione di una relazione da parte degli amministratori da redigere anteriormente rispetto all’operazione. Tale relazione deve illustrare le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve essere depositata presso la sede sociale trenta giorni prima dell’approvazione dell’operazione a disposizione dei soci.
Si tratta quindi di una relazione anteriore all’operazione, redatta dagli amministratori e con un contenuto preciso: illustrare le ragioni che hanno indotto ad effettuare un’operazione di mutamento così radicale del codice organizzativo e i suoi effetti.
Si è in presenza, pertanto, di un’informazione fornita dagli amministratori diretta a motivare la scelta ed illustrarne le conseguenze: pare, quindi, una regola estensibile anche al caso di trasformazione dell’azienda speciale in fondazione di partecipazione.
La seconda parte del primo comma dell’art. 115 T.u.e.l., come si è già osservato, disciplina le modalità di determinazione del capitale iniziale delle società di capitali derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali: quest’ultimo è fissato nella deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione dell’azienda speciale risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all’importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime; l’eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo dove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio dell’azienda.
Sembra che tale regola possa trovare applicazione anche nel nostro caso, adattandola alle peculiarità della fattispecie, al fine di determinare il patrimonio della fondazione e i vincoli sullo stesso.
La relazione prevista nel comma terzo dell’art. 115 è collegata a tale norma: infatti, ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, in un momento successivo rispetto alla trasformazione e precisamente entro tre mesi, gli amministratori devono richiedere ad un esperto designato dal Presidente del Tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343, primo comma del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione, e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima.
Pare una norma strettamente correlata alla natura dell’ente risultante dalla trasformazione e quindi non estensibile all’ipotesi della trasformazione in fondazione. La finalità della stessa è ovviamente quella di fornire una tutela ai creditori, una garanzia di effettività del capitale sociale. Ma occorre osservare che, nel nostro caso, ai creditori viene concessa la tutela costituita dal diritto all’opposizione. La sussistenza di un patrimonio congruo è poi oggetto di valutazione da parte dell’Autorità governativa in sede di costituzione della fondazione o del notaio, se si tratta di ente del Terzo Settore.
Piuttosto potrebbe venire in considerazione il primo comma dell’art. 42 bis c.c. (in tema di trasformazione da associazione in fondazione o viceversa) per cui l’organo di amministrazione deve predisporre una relazione concernente la situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione e quindi un bilancio infrannuale che consente ai creditori di avere una situazione aggiornata.
Come è proprio delle trasformazioni, la fondazione conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli processuali.
Trattandosi di fondazione di partecipazione potranno essere previste la struttura aperta e quindi la successiva partecipazione di soggetti pubblici o privati, la modalità di composizione e di nomina dei vari organi, le modalità di incremento del patrimonio.